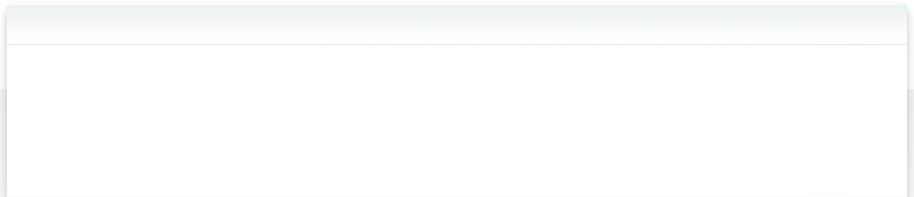Cinzia Vaccari - Un giorno dopo l’altro
Scendo dal l’auto con gesti a rallentatore, mi vedo movimento rassegnato. Quante auto ci sono in questo parcheggio? Neanche tante, è semivuoto. La cosa che mi fa veramente capire che ci metterò non meno di tutta la mattina è l’enorme numero di biciclette e motorini scassati, tutti accatastati in prossimità della grande porta a vetri scorrevole. Mi avvicino agli scalini, zerbino di porta, dove due bellissime bambine di origine araba stanno giocando ad un gioco tutto loro.
Mi fermo un momento per riempirmi gli occhi dei loro gesti e di quel muovere di braccia così elegante a polsi snodati, che leggiadri imitano le madri nel momento del the, un rituale che le donne arabe compiono per una vita intera con un aggraziato movimento, unico gesto erotico dell’avambraccio, unica carne scoperta. Loro, le bambine, tantissime volte lo hanno visto fare sotto tende, su tappeti coloratissimi, e quindi osservo le loro movenze, lasciandomi accarezzare da quello che vedo. Il primo giro di the è amaro come la vita, il secondo dolce come l’amore, il terzo, ultimo giro, soave come la morte. Non sono tanto diverse dalla bambina che ero: anch’io invitavo le mie amiche per il caffé e a memoria, precisa, con la stessa cura, imitavo i gesti di mia madre e della nonna nella precisione di quel momento. Tazzine plastificate e cucchiaini intinti nella sabbia al posto dei bianchi cristalli di zucchero.
Sorrido, pensando che è proprio vero le donne sono le stesse in tutto il mondo. Le piccole donne diventano grandi dopo anni e anni di giochi che si trasformano in un lungo allenamento, preparazione al futuro. Questo non ci fa molto femministe, ma è una verità. Le loro manine gentili mi allungano una tazzina o forse un bicchierino immaginario, veloci mi offrono un the che non c’è in un bicchiere che nessuno vede ma che afferro e stringo, portandomi velocemente il niente alle labbra, soffiando il fumo che sale dal nulla di quel the caldo che vediamo solo noi, le uniche ad assaporarlo. A malincuore mi congedo da loro, ringraziandole con un sorriso e un cenno del capo; esistono gesti che non hanno bisogno di lingua, né di pronuncia. Mi sento bene, mi sento piccola e, per un istante, devo fare uno sforzo di concentrazione per ricordare che sono lì per sistemare un errore burocratico e non per giocare. Peccato. In certi momenti, e questo è sicuramente uno di quelli, vorrei permettermi il lusso di giocare, a testa leggera e a spalle scariche di tutto. Entro spiata dalle telecamere a circuito chiuso, occhio in tutto il perimetro esterno della Questura, passo come un fosso tra due sponde, due pareti piene di questi cartelli che ti avvisano di essere corretto perché sei spiato, il grande occhio ci riprende e la sicurezza è garantita. O almeno i malintenzionati sono stati informati.
Attendo che il piantone del punto di ascolto, il primo smistamento mi dia un orecchio, mentre con lo sguardo comincio a leggere legende che ti spiegano in quale ufficio andare per fare cosa e in quali orari, e mi domando perché siano solo in italiano, visto che si chiama Ufficio Immigrazione e ci sono solo stranieri. Quindi, al centro dell’atrio, aspetto il mio turno e nel mentre mi giro con una piroetta lentissima, cercando di capire a che punto siano le mie compagne di the. Vengo richiamata dalla voce del poliziotto e finalmente tocca a me.
«Buongiorno.»
«Dica.»
«Guardi, avevo bisogno di un’informazione. La ragazza che lavora a casa mia ha fatto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Le sono state comunicate la data e l’ora dell’appuntamento in Questura per il fotosegnalamento…»
«Quindi?» chiede il mio interlocutore.
«Quindi l’orario mi lascia pensare che ci sia un errore. Dice di presentarsi il tal giorno alle 02:03, e volevo sapere se questi uffici sono aperti anche la notte, 24 ore su 24. Se è così, rispetto l’orario e l’accompagno, ma se non è così non vorrei mai ci fossero dei problemi che possano compromettere il suo permesso di soggiorno in Italia.»
Il poliziotto mi guarda, si fa una risatina e, dopo avermi chiesto scusa, mi indica l’ufficio al quale mi posso rivolgere. Nella grande sala d’aspetto ho la visione esatta di quante siano le etnie di questo pianeta. A occhio e croce, tra seduti e in piedi non vedo meno di ottanta persone. Tra il caldo esagerato che regna in quel luogo e i vari odori (un misto di profumi e deodoranti che riconosco, scadenti, profumi di spezie che mi sembrano stranieri come i loro padroni, poi aglio, fritto e sudore vecchio e fresco, forse già anche il mio si è mischiato al loro) mi appoggio spalle al muro di questo angolo vicino alla finestra, cerco di riprendermi e di capire se esiste una fila o se bisogna prendere il famoso numerino che ormai manca solo in chiesa, o chissà che altro devo fare.
Mi sento una sardina in scatola, sebbene la mia bilancia e i miei vestiti dicano altro ogni mattina, il mio pensiero un po’ stordito, invece di concentrarsi sul capire cosa fare, vaga tra un viso, una scarpa e una bellissima gonna indossata da una ragazza di origine africana, la bocca affamata di un neonato che succhia avido e incazzato il capezzolo allungato a tettarella della donna che lo ha dato alla luce da pochi mesi su questo pezzo di terra straniero. È nato già da immigrato, anzi, lui è l’unico non immigrato della sua famiglia. La fila di sedie di fronte al mio muro è occupata in parte da alcune donne che riconosco ucraine dal suono delle loro velocissime parole, parole che sento spesso durante le telefonate che riceve la signora che assieme a me si occupa di mia madre. La faccio spesso arrabbiare prendendola in giro con alcune parole che ho imparato di quella lingua che le mie orecchie e il mio cervello considerano veramente una lingua complessa, complicata, veramente molto straniera.
Mentre penso a questo, passa tra il mio pensiero e le loro spalle sedute un agente donna e le chiedo come fare per trovare lo sportello a cui devo recarmi, se devo fare la fila e, se sì, in che modo si accede a questa. Lei mi guarda un po’ infastidita. Sarà la puzza, il caldo, o magari il desiderio di essere in cima alla moto, in servizio come i Chips, ma a lei è toccato fare il poliziotto lì dentro, dove deve svolgere il lavoro d’ufficio, fotocopie di passaporti di persone che, giorno dopo giorno dopo giorno la rendono sempre più scontrosa e scontenta, o forse è solo stanca e, invece di cercare di mantenere l’ordine e di rispondere a domande uguali ma formulate da voci straniere e accenti incomprensibili, vorrebbe solo essere al mare o in un qualsiasi altro posto. Anch’io vorrei spesso essere in un altro luogo, magari in un’altra vita, e invece sono lì in piedi, di fronte a lei.
L’unica risposta che ottengo è: «Aspetti e verrà chiamata».
Si gira, schiva alcuni bambini cinesi che stanno giocando a terra con alcune automobiline da corsa e se ne va, facendosi varco sbuffante tra le sardine di questa confezione. Basita, ad alta voce chiedo: «Ma chi mi chiama se nessuno sa che sono qui?» Non ho un appuntamento, le mie impronte non interessano, non entrano nel computer con le altre mani che sono qui con le mie. Io, per questi uffici, né oggi né domani sarei dovuta essere qua. Ma lei è già oltre, ad una porta che separa i brutti dai belli, i buoni dai cattivi, gli italiani dagli altri tutti.
Sorrido alle mie compagne di the, entrate a cercare le loro mamme, stanche, accaldate di gioco e afa di pianura, e decido di chiedere permesso a chi è tra me e lo sportello. Aspetto il momento buono per ri-ri-porre la mia unica domanda, sempre e solo quella. Devo venire o no alle 02:03 di notte a portarvi le dita attaccate alla donna dell’est che lavora per me? Comincio a sentire l’incazzatura salirmi fino all’attaccatura dei capelli, nervini che si muovono come una marcia di formiche fra le ossa e la pelle del mio cranio sudato, il fastidio di quello che vedo e il modo in cui sono trattate queste persone mi inaridiscono anche la bocca e non trovo più saliva dentro di me. Arrivo di fronte alla fila dei quattro sportelli che smistano la fila per gli stranieri che lasciano le impronte per la prima volta e quelli che devono solo rinnovare il permesso e collocare il dito nell’apposito strumento che permetterà di capire se le impronte rilasciate due anni prima corrispondono o no a quelle di oggi.
Aspetto che si liberi uno dei quattro agenti e mi avvicino in punta di piedi, educatissima e con tutta la gentilezza che riesco a trovarmi in fondo allo stomaco, sorrido e comincio a chiedere… Non riesco a pronunciare più di un qualche suono che l’uomo con un tono sprezzante esclama: «Ehi, tu! Aspetta il tuo turno, capito? Capito quello che ho detto?» E sbuffa. Ho esaurito la pazienza, la calma e l’educazione ereditata dai miei avi e tramandatami con tanta insistenza da mia madre. Rapidamente, cerco nella testa come dire a questo signore italiano che mi ha scambiata per una straniera che ho bisogno solo di una stramaledetta informazione, ma tra fronte e cervello mi gira altro. Rimbalzano parole come “la paura e l’ignoranza non ti hanno mai permesso di vedere come umani questi stranieri, immigrati in Italia e in altri Stati per cercare un lavoro che permetta loro di sfamare i propri cari e garantire ai loro figli la possibilità di non essere più abitanti del Terzo o del Quarto Mondo?
La tua “ariana” presunzione ti rende cieco e di poca memoria: i tuoi nonni e forse anche i tuoi genitori sono stati lavoratori stranieri in America, Argentina, Svizzera o chissà dove… Togliti i paraocchi e non vedere gli stranieri solo come delinquenti e spacciatori, sono persone. Ti rinfresco la memoria, vuoi? Ci sono paesi che ci ricordano nel male solo per questo. Finiscila, presuntuoso scribacchino.
Hai mai fatto caso che anche gli stranieri sono fatti come me e te? Anche se non ci credete, tu e tutti quelli come te, loro sono di carne ed ossa. Queste donne sono come tua moglie o tua madre, amano, fanno figli, hanno le stesse tette, forse sono di pigmento colorate diversamente, ma il latte che ne esce è bianco come quello che ha nutrito te. O magari sono di carne solo quando fa comodo pagarle per portarsele a letto o per farci sesso sui sedili delle automobili prima di scaricarle sul ciglio della strada? Magari perché in quel caso il colore non si vede. Anzi, per molti è proprio il colore diverso ad ingrossare il cavallo dei calzoni. La razza e il colore non importano quando molti di noi hanno la necessità di avere in casa qualcuno che pulisca o si prende cura dei nostri malati, non vi è nessuna diversità quando si sceglie una moldava o un’ucraina, clandestina perché costa meno e non si versano neppure i contributi. Per non parlare di quei ragazzi africani in fonderia o occupati a fare dei lavori pesanti, scomodi e malsani che noi non vogliamo più fare. In questi casi, ben vengano nel nostro paese.”
Termino l’elenco dei pensieri che mi affollano la mente, rendendomi conto di quanto l’uomo sia scocciato dal mio stare ancora lì in piedi davanti a lui, la bocca piegata in un broncio da bambina offesa in gioco dalle amiche. Riesco solo a rispondere: «Ehi, “tu” lo dirà poi a sua sorella», ma lui è già con lo sguardo oltre la mia statura e guarda il prossimo sulla porta, perché quel coglione, mentre parlavo, ha chiamato il nome successivo sulla lunga “lista di oggi”, bestemmiando qualcosa sul fatto che non riuscisse a capire come e se avesse pronunciato correttamente quel nome.
Decido di fare la fila nello sportello di fianco, ma poi, che fila? Io non rientro in quella lista di nomi sui quattro terminali di fronte alle quattro persone oltre il vetro. Mi ritrovo dietro alle donne ucraine di prima, ora non più sedute. Le loro nuche sono ad un palmo dal mio naso e ne percepisco i profumi diversi, forti di fragranze intense ed eccessive, uniti all’odore della pelle. Continuo il mio elenco mentale delle cose da fare oggi, anche le più insignificanti: prendere il giornale, passare in lavanderia per ritirare i piumoni lavati e messi sottovuoto per salvare spazio nell’armadio… Faccio questo esercizio quando voglio fregare il dolore, visto che la rabbia di poco fa si è trasformata proprio in questo, nel male che provo verso questa nostra ignoranza e indifferenza. Un dolore che mi punge come una spina conficcata in un piede, quando penso che dovremmo imparare ad aprirci verso ciò che non conosciamo, quante cose non conosciamo per colpa di questo nostro tenerci fuori, quante occasioni perdiamo nel chiuderci dentro alle nostre vite, barricati nelle nostre proprietà, siano esse le nostre piscinette da cortile eccessivamente clorate o la terra arida in cui piantiamo le stesse margheritine o la stessa lavanda, anno dopo anno. Siamo restii ad azzardare sul colore di un fiore, figuriamoci sul colore della pelle del nostro nuovo vicino. C’è il rischio che non faccia pendant con le aiuole.
Siamo così chiusi nel “nostro” che non facciamo giocare neppure il cane con un suo simile per la paura che si scambino le pulci, non parliamo neanche della possibilità che i nostri figli giochino con altri bambini, magari di etnie diverse, che portano malattie nuove o antiche da noi debellate già da alcune generazioni. Torno a fatica in questo luogo. I miei occhi si fissano nuovamente su queste nuche, con code e conci che ho ancora davanti. Sono ancora bloccata qui, in questa fila paralizzata che non avanza. Oggi come ieri, domani come oggi, chissà se le persone come l’impiegato ufficiale (o l’ufficiale impiegato) di prima hanno mai notato che sia noi che loro abbiamo la stessa attaccatura dei capelli nel coppetto, che nello stesso modo le zanzare affondano il loro pungiglione nella nostra carne, che i nei e le lentiggini disegnano i loro corpi come i nostri.
Da bambina pensavo che unendo con la matita tutti i nei e le picce del corpo di mia madre sarebbe uscito un disegno o un’immagine e che se l’avessi indovinata prima di finire avrei vinto qualcosa. In questo momento penso che se facessi lo stesso sui corpi dei presenti, magari uscirebbe lo stesso disegno, di colori, dimensioni e prospettive diverse, ma sempre la stessa immagine. Allargo lo sguardo a zoom, inquadrando tutti. Compiamo gli stessi gesti nell’accompagnare le parole con le mani mentre conversiamo con gli altri. Ci soffiamo il naso con la stessa spinta e stringiamo il fazzoletto, sgualcendolo, nella stessa maniera. Sbadigliamo aprendo la bocca lentamente allo stesso modo, anche se le nostre lingue non usano lo stesso alfabeto e i nostri denti sono più o meno curati. Probabilmente anche il nostro ansimare di piacere ha lo stesso suono. Ascolto le risate di queste donne e riconosco il suono che producono. Mi sembra di sentir ridere mia madre, mia nonna, una sorella e la mia migliore amica.
Ripenso alla badante di mia madre e alle sue amiche che in questi anni mi ha presentato. Una cosa le accomuna: il grado d’istruzione. Forse nessuno ci pensa, ma queste donne che lasciano figli, cari e la propria terra, spinte dal bisogno di lavorare per sfamare le loro famiglie, per venire a lavare culi dalle nostre parti, sono quasi tutte laureate. Dieci di loro e dieci italiane appartenenti alla generazione ‘65/’75: sei o sette delle prime hanno una laurea appesa in una qualche stanza di casa loro ad ingiallirsi, mentre tra le seconde forse forse arriviamo a tre o quattro, e voglio essere generosa. Quindi smettiamo di puntare il dito, altrimenti passiamo da accusatori di ignoranza a portatori di ignoranza. Decido di uscire da questo stato di standby in cui mi obbliga la fila e mi avvicino ad un altro sportello. Non lascio il tempo all’uomo oltre il vetro di aprir bocca e, mentre lui mi fa segno di appoggiare il dito sopra l’apposito macchinino che, collegato al computer, controlla le impronte, comincio a formulare la solita e ormai vecchia domanda, l’unica per cui ormai da tre ore aspetto una risposta. Parlo velocemente, il più chiaramente possibile e con un tono sostenuto che non lascia spazio ad interruzioni da parte del mio interlocutore. Ce l’ho fatta, finalmente.
Mi dice a voce che avrei dovuto arrivarci da sola a capire che era un errore e che si trattava delle 14:03, probabilmente innervosito dal fatto che oggi non sia stata l’unica a segnalare questo problema. Mi guarda e aggiunge: «02:03 pomeridiane», con un tono di voce bolso che lo costringe, suo malgrado, a prestare attenzione. Con un sorriso calmo e accattivante, che lo innervosisce ancora di più, replico che per intendere “pomeridiane” magari si può aggiungere un p.m. che non sta per polizia militare. Esco senza ringraziare, non mi passa neppure per la mente. Ringraziare di che, poi? Augurare il buongiorno a chi? A chi oggi come ieri e domani come oggi tratterà sempre le persone come se non le vedesse, anzi come se proprio la presenza di questa gente gli impedisse la visuale verso il futuro.
Esco sotto il sole di questo caldissimo giorno qualsiasi di giugno, l’aria bollente che l’asfalto butta su mai mi è parsa tanto piacevole. Salgo in auto, che si è trasformata in un forno che mi cuoce il respiro, ma va bene anche questo. Nella mia lista del fare oggi, anche questa è fatta. Mi immetto meccanicamente in tangenziale, facendo un pensiero buono verso gli stranieri e mentalmente mi vergogno di essere simile allo scrivano e alla donna Chips, ma di certo non figlia della stessa ignoranza, stupendomi di non riuscire a formulare un pensiero cattivo nei loro confronti, e provo una compassione profonda. Sposto il mio pensiero altrove, sperando che oggi sia stato un po’ diverso da ieri e domani possa essere, magari, un po’ migliore.
Casa della Solidarietà - Rete Radié Resch di Quarrata
Associazione di solidarietà internazionale